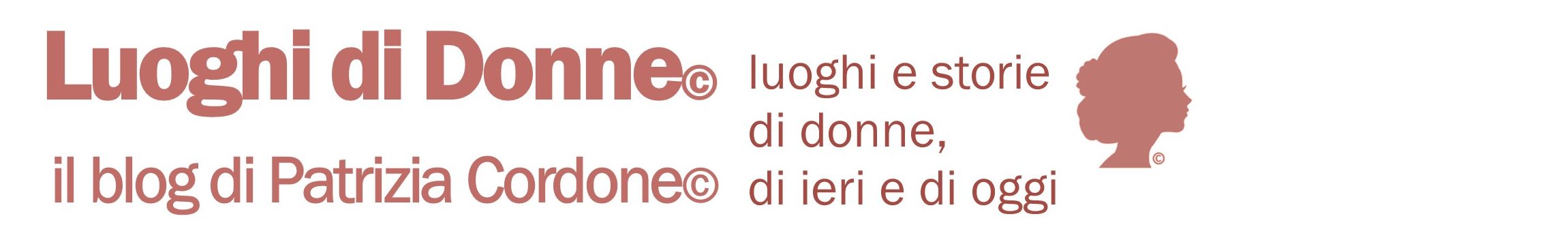Non è soltanto il titolo di un suo celebre libro, lei fu proprio così. Sin dall’infanzia fino ad età avanzata viaggiò, ad ogni tappa scrisse libri, poi rivisti, aggiornati, a seguire l’iperbole della sete di conoscenza del mondo. A cominciare da quello classico di cui fu cultrice ed a cui si ispirò per il romanzo storico “Memorie di Adriano” edito nel 1951, con una gestazione iniziata nel 1924. Prima donna nominata dall’Academie Française, riparata negli Usa per sfuggire agli orrori dell’avvento nazista trattenne sempre un fortissimo legame con i luoghi dell’infanzia, oggi preservati con un museo ed un parco visitabili.
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
Dopo trecento anni di monopolio maschile fu nominata componente all’Accademia di Francia. Fu un riconoscimento dovuto alla sua vasta cultura classica, alla sua capacità di scrittrice sapiente, di saggista acuta, di poetessa ineffabile, di traduttrice e di critica letteraria. Il suo stile di vita, la sua sete di conoscenza e l’approfondimento metodico parevano ispirarsi alla cultura umanistica del rinascimento, supportata da ottime letture di libri antichi. Nacque nel 1903 a Bruxelles, figlia unica di M. Cleenewerck de Crayencour, discendente dell’alta borghesia terriera delle Fiandre francesi e di Fernande de Cartier de Marchienne, appartenente alla nobiltà belga, deceduta dieci giorni dopo la sua nascita. Crebbe dalla nonna paterna, Noémi Dufresne e dal padre, anticonformista e grande viaggiatore a Lille, mentre d’estate si trasferivano al castello di famiglia situato in cima al Mont Noir nel comune di Saint-Jans-Cappel, costruito nel 1824 dal bisnonno A. Dufresne (1801-1875) e che rimarrà di proprietà della famiglia Dufresne fino alla morte della nonna paterna nel 1909. Quattro anni dopo averlo ereditato il padre lo vendette, il castello fu distrutto durante la prima guerra mondiale. Potendo avvalersi di insegnanti privati non fu iscritta a nessuna scuola, da privatista conseguì il diploma di maturità classica a Nizza nel 1919. Per il resto la formazione avvenne tramite le frequentazioni delle rappresentazioni classiche a teatro, le visite ai musei, le abbondanti letture della biblioteca paterna, da sola imparò a leggere i poeti italiani in lingua originale ed approfondì la letteratura europea del diciannovesimo secolo. Avanti negli anni disse: “il vero luogo di nascita é il luogo in cui per la prima volta ti sei guardato in modo intelligente: i miei primi paesi erano libri“. Nel 1921 appena diciottenne pubblicò “Le Jardin des chimères” firmandosi “Marguerite Yourcenar”, l’anagramma del cognome Crayencour con l’omissione di una C, lo pseudonimo divenuto il nome legale con la cittadinanza americana nel 1947, seguito l’anno successivo da una raccolta di poesie, “Les dieux ne sont pas morts”. Frequenti furono i suoi viaggi con il padre: oltre in Gran Bretagna durante la prima guerra mondiale, in Italia, dove nel 1922 assistette alla marcia su Roma. Nel 1924 approdò per la prima volta a Villa Adriana di Tivoli, la cui visita la calamitò, iniziò a redigere i “carnets des notes”, che avrebbe utilizzato per la stesura delle celebri “Memorie di Adriano”.
Queste tappe le consentirono di coltivare un’autentica cultura cosmopolita sondando tutto il sapere europeo. D’altronde la sua natura di “pellegrina e straniera” era quanto di più autentico della sua personalità sia da giovane che da adulta. Dal 1926 visse per tre anni in Svizzera, volle mettersi alla prova della scrittura con un mélange di generi letterari, scrisse “Alexis” il primo romanzo, elogiato dai migliori critici, tra cui E. Jaloux. In Svizzera conobbe molti intellettuali italiani in esilio, le cui considerazioni confluirono in suo romanzo “Denier du rêve” pubblicato nel 1934 e da lei revisionato nel 1959. Intanto nel 1929 scomparve il padre, da tempo malato e da lei accudito, lasciandole un’eredità sufficiente per i suoi numerosi viaggi attraverso tutta l’Europa fino ai paesi balcanici. Pressocché ad ogni tappa corrispose alla stesura di scritti sempre pubblicati anche in date differite e con edizioni aggiornate. Tra il 1934 ed il 1938 soggiornò molto in Grecia, nel 1935 compì una crociera nel mar Nero, durante la quale compose “Nouvelles Orientales”, aneddoti di vita aggrovigliati alla mitologia, libro pubblicato da Gallimard nella collezione “La renaissance de le notizie” nel 1938. Durante questo periodo tradusse, assieme a C. Dimaras, le poesie di C. Cavafis, la cui raccolta preceduta dalla sua presentazione fu editata nel 1958. Nel 1937 ritornò in Gran Bretagna a Londra per incontrare Virginia Woolf, da cui accettò la proposta di traduzione dall’inglese al francese de “Le onde”, pubblicata nel giro di pochi mesi. A settembre dello stesso anno compì il primo viaggio verso gli Usa, dove conobbe anche qui come in Svizzera, degli intellettuali esuli, stavolta europei e visitò alcuni stati del sud. Nel 1938 tornò in Europa, a Capri, dove scrisse “Le Coup de Grâce”, ambientato nel 1919 durante la guerra di indipendenza lettone e la battaglia tedesca contro il bolscevismo, pubblicato nel 1939; nel 1938 fu stampato “Les Songes et les Sorts”, un piccolo testo autobiografico quasi del tutto sconosciuto al grande pubblico; lo stesso anno fece tappa a Vienna, la cui permanenza le rivelò la ferocia del nazismo con l’annessa persecuzione ebraica. Durante questi anni si interessò di storia contemporanea, di movimenti politici come l’anarchia ed il socialismo, della filosofia e della poesia tedesca; approcciò le prime prime traduzioni di testi indiani e dell’estremo oriente. Nel 1939 le apparve con chiarezza lo scenario lugubre, che stava investendo l’Europa con lo scoppio della seconda guerra mondiale. Decise di trasferirsi negli Usa assieme alla sua amica Grace Frick, allora docente di letteratura britannica a New York, conosciuta a Parigi qualche anno prima. L’intento era di restarci per poco tempo, in realtà si stabilì qui per dodici anni. Abitò a New York, dove per la prima volta nella sua esistenza dovette fare i conti con le necessità materiali quotidiane. Nel 1942 essendo rimasta sprovvista di danaro, grazie all’aiuto della sua amica, trovò un lavoro di insegnante di italiano e di francese alla periferia di New York. Si stabilì sull’isola di Monts Déserts, Maine, in una casa, che battezzò come la “Petite-Plaisance”, dove trascorse il resto della sua vita. Intanto la sua amica Grace Frick, più agiata di lei, l’aiutò economicamente e con il tempo divenne la traduttrice dei suoi scritti dall’inglese al francese.
Nel 1949 ottenuta la cittadinanza americana, si fece inviare i suoi bauli recuperati dall’hotel Meurice di Losanna, il cui riordino delle carte contenute le riservò una sorpresa: i primi appunti scritti durante la sua tappa a Villa Adriana a Tivoli, visitata nel 1924. Per lei fu anche una folgorazione inattesa, probabilmente anche per riallacciare i fili della sua esistenza attuale con la gioventù. Aveva bisogno di tempo per riordinarli e scrivere il suo romanzo più famoso “Memorie di Adriano”, quindi chiese un congedo dal suo contratto scolastico, seppure brevemente riprese l’insegnamento di letteratura e storia dell’arte francese fino al 1953. Ancora prima della stesura del romanzo esitò circa la scelta del protagonista tra l’imperatore Adriano ed O. Khayyam, studioso persiano del Medioevo, ma essendo lei da sempre una classicista di formazione optò per il primo. Nel modo più esaustivo possibile raccolse tutta la documentazione storica utile, lesse integralmente le opere letterarie del tempo di Adriano. In modo spasmodico, incessante, approfondì, si dedicò ad ulteriori letture fino a quando pronta con il compimento della ricerca e forse dopo un’incubazione di tanti anni, scrisse il romanzo, tutto sommato in breve tempo. Scelse lo stratagemma del racconto in prima persona, di una lettera indirizzata dall’imperatore Adriano al suo successore, Marco Aurelio, con cui ricognizza la sua vita, la gioventù, l’impegno politico, le letture alla soglia della vecchiaia. Celebri sono i brani tratti dal libro: “un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più… Cerchiamo d’entrare nella morte a occhi aperti… La vita è atroce; lo sappiamo. Ma proprio perché aspetto tanto poco dalla condizione umana, i periodi di felicità, i progressi parziali, gli sforzi di ripresa e di continuità mi sembrano altrettanti prodigi che compensano quasi la massa immensa dei mali, degli insuccessi, dell’incuria e dell’errore“. Nel 1951 fu pubblicato sempre dallo stesso editore di fiducia, Gallimard. Il successo internazionale fu immediato: nel 1952 fu assegnato il Prix Femina-Vacaresco, acclamato dall’Accademia di Francia; tradotto in inglese nel 1954, conquistò il “Newspaper Guild of New York Page One Award”.
Tra una bozza ed una stesura definitiva, tra una pubblicazione ed un premio, continuò a viaggiare per diletto e per conferenze. Andò in Scandinavia, in Belgio, in Olanda, in Alaska, mai appagata di viaggiare, di conoscere, di esplorare altri confini, in parte per estraniarsi, in parte per sondare la contemporaneità con le sue problematiche. Attorno agli anni cinquanta negli Usa fu attiva con i movimenti a difesa della pace, contro il riarmo nucleare, per la protezione ambientale, temi di cui scrisse molti articoli. D’altronde era fermamente convinta: “noi abbiamo una sola vita: se anche avessi fortuna, se anche raggiungessi la gloria, di certo sentirei di aver perduto la mia, se per un solo giorno smettessi di contemplare l’universo“. Nel 1968 pubblicò “L’Œuvre au noir” ed anche dei saggi. Ulteriori riconoscimenti le giunsero: nel 1970 la nomina di componente dell‘Accademia reale belga di lingua e letteratura francese; nel 1971 la Légion d’honneur; nel 1974 – Gran Premio Nazionale per la Cultura; nel 1977 – Gran Premio dell’Accademia di Francia; nel 1982 nominata componente dell’American Academy of Arts and Letters; nel 1986 insignita della medaglia d’oro del National Art Club. Ma il riconoscimento più importante le fu attribuito dall’Accademia di Francia nel 1980, nomina contrastata in un’istituzione maschile da sempre. La candidatura avanzata da J. d’Ormesson provocò delle discussioni accese e controverse circa la nomina di una donna, seppure di talento letterario assodato, la prima in questa istituzione. Alla fine il responso fu affermativo, segnando una tappa importante, che avrebbe riguardato altre donne eminenti come Béatrix Beck e Danièle Sallenave. Ancora altri viaggi seguirono verso nuove mete come l’Africa e l’Asia, studiò il giapponese. Gli anni avanzavano inesorabili, eppure mai l’abbandonarono i ricordi dei luoghi dell’infanzia ed il desiderio di ricostruire la storia familiare. Nel 1974 fu pubblicato “Souvenirs pieux“, seguito da “Archives du Nord” del 1977 e da “Quoi ? L’éternité” pubblicato postumo nel 1988, i tre libri costituiscono la trilogia autobiografica “Le Labyrinthe du monde“. Disse: “finché un essere inventato non ha importanza per noi tanto quanto noi stessi, non è niente“. Dietro suggerimento di un amico L. Sonneville, nel 1985 in sua presenza fu inaugurato il “Musée communal Marguerite Yourcenar” proprio al Mont Noir, dove lei infante visse. All’interno sono stati ricreati gli ambienti a lei familiari.
Da tempo ammalata, scomparve negli Usa a dicembre 1987, il funerale venne celebrato ad un mese del suo decesso e qui le sue ceneri furono raccolte nel cimitero Brookside, di Somesville, nel Maine. Prima della dipartita aveva scelto con cura la scritta tratta da “L’Œuvre au noir” per l’epitaffio della sua lapide, così com’é oggi: “possa piacere a Colui che deve dilatare il cuore dell’uomo per la misura di tutta la vita“. In occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa il Centre international de Documentation Marguerite Yourcenar, Cidmy di Bruxelles, organizzò molte iniziative in Europa, di cui alcune in Italia. Le sue opere continuano ad essere ristampate, la sua memoria permane anche laddove nacque, cioé in Belgio. Nel 1982 anzitempo alla sua dipartita aveva creato la Fondazione Marguerite-Yourcenar, posta sotto l’egida della Fondation de France per la protezione della riserva naturale di Monts des Fiandre ed anche il “Musée communal Marguerite Yourcenar” proprio al Mont Noir, entrambi i luoghi, dove lei infante visse. Esaudendo un suo antico desiderio: “se avessi vent’anni di meno, troverei una riserva naturale a Mont-Noir, dove ho trascorso gran parte della mia infanzia“. Per chiudere il cerchio della sua vita.






opere tradotte in italiano – romanzi e raccolte di poesie: Alexis o il trattato della lotta vana (1929), trad. di Maria Luisa Spaziani, Milano: G. Feltrinelli, 1962; Il colpo di grazia (1939), trad. di Maria Luisa Spaziani, Milano: G. Feltrinelli, 1962; Memorie di Adriano (1951), trad. di Lidia Storoni Mazzolani, Torino: Einaudi, 1963 (con i Taccuini di appunti, Torino: Einaudi, 1981); L’opera al nero (1968), trad. di Marcello Mongardo, Milano: Feltrinelli, 1969; Care memorie (1974), trad. di Graziella Cillario, Torino: Einaudi, 1981; Archivi del Nord (1977) (trad. di Graziella Cillario, Torino: Einaudi, 1982; Novelle orientali (1938), trad. di Maria Luisa Spaziani, Milano: Rizzoli, 1983; Come l’acqua che scorre. Tre racconti (1982), trad. di Maria Caronia, Torino: Einaudi, 1983. (Contiene: Anna, soror…, Un uomo oscuro e Una bella mattina); Fuochi (1936), trad. di Maria Luisa Spaziani, Milano: Bompiani, 1984; I doni di Alcippe (1956), trad. di Manrico Murzi, Milano: Bompiani, 1987 Quoi? L’Eternité (1988, postumo), trad. di Graziella Cillario. Torino: Einaudi, 1989; Racconto azzurro e altre novelle (1993, postumo), trad. di Francesco Saba Sardi, Milano: Bompiani, 1993 (contiene i racconti giovanili Racconto azzurro, La prima sera, Maleficio); I trentatré nomi di Dio, trad. di Ginevra Bompiani, Roma: Nottetempo, 2003; Moneta del sogno (1935), trad. di O. Del Buono, Milano: Bompiani, 1984; trad. di Stefania Ricciardi, Milano: Bompiani, 2017.
saggi: Con beneficio d’inventario (1962), trad. di Fabrizio Ascari, Milano: Bompiani, 1985; Mishima o la visione del vuoto (1981), trad. di Laura Guarino, Milano: Bompiani, 1982; Il tempo grande scultore (1983), trad. di Giuseppe Guglielmi, Torino: Einaudi, 1985; Pellegrina e straniera (1989) , trad. di Elena Giovanelli, Torino: Einaudi, 1989; il giro della prigione (1991), trad. di Fabrizio Ascari, Milano: Bompiani, 1991; Scritto in un giardino, trad. di Carlo Angelino, Genova: Il melangolo, 2004; Il segreto e il sacro. Saggi sulla letteratura e sulla traduzione, 1966-1984, a cura di Camillo Faverzani, Roma: Bulzoni, 2009; La mente nera di Piranesi, trad. di Fabrizio Ascari, Tesserete (Svizzera): Pagine d’arte, 2016.
premi: 1968 – Prix Femina; 1972 – Prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre-de-Monaco; 1974 – Grand Prix national des lettres; 1977 – Gran premio di letteratura dell’Accademia francese; 1983 – Premio Erasmo.
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
avete apprezzato l’articolo? condividete il link via facebook e gli altri canali social media