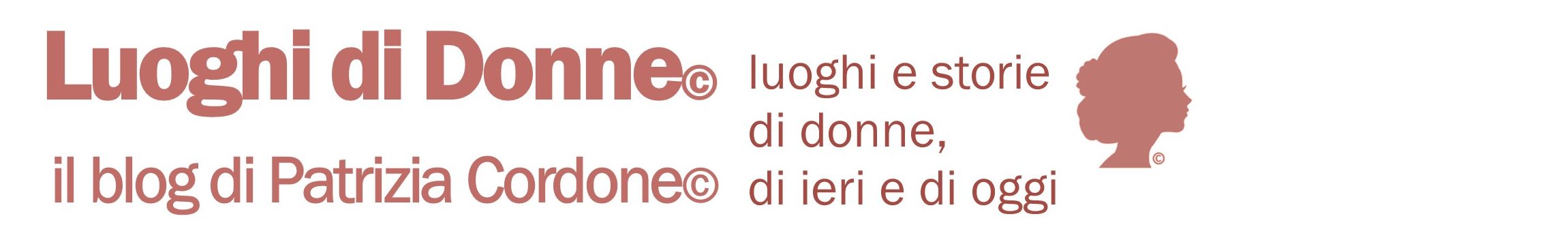articolo di Patrizia Cordone© – Il canone estetico della pelle eburnea, le regole della “modestia” dell’abito femminile, il tabù del nuoto, il privilegio delle vacanze termali appannaggio dell’alta società, il “Grand tour”, la “Belle Epoque”, l’elioterapia merito di uno scienziato siciliano, le invenzioni tessili, i laboratori Bayer e molto altro sono le tappe attraverso cui si dipana la storia del costume da bagno femminile e …. del costume sociale interdipendenti l’uno con l’altro. Pronti per un viaggio nel tempo, anzi un vero tuffo nella storia? Allora si parte e buona immersione!
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
Il nuoto, la vacanza balneare, l’abbronzatura, il costume da bagno sono consuetudini di un certo consumismo e della modernità, non del passato. In età preistorica il nuoto può essere stato una pratica necessaria per procacciarsi il nutrimento dalla pesca, ben lungi dall’essere una pratica agonistica oppure ricreativa. La vacanza balneare è stata appannaggio delle classi sociali abbienti a partire dalla fine del diciannovesimo secolo esclusivamente presso le prime terme e soltanto per ragioni curative della salute. L’abbronzatura è stata ritenuta a lungo disdicevole dalle classi agiate, che ostentavano il loro status sociale con la “peau de lune”, pelle bianca e diafana, sinonimo di nobiltà e di benessere economico, giacché i coloriti bruni erano tipiche prerogative delle persone umili, dei contadini, gli operai ed i venditori ambulanti; ma si badi bene trattarsi di un emblema della bellezza risalente all’antica Roma, dove secondo molte testimonianze archeologiche le nobildonne esaltavano la carnagione pallida simile al richiamo del colore della porcellana. Quanto al costume da bagno esso ha seguito di pari passo l’evoluzione della pratica del nuoto, dell’usanza della vacanza balneare marittima e dell’abbronzatura come conquista sociale di massa, in ogni caso irregimentato da regole restrittive pari per donne ed uomini all’insegna della pudicizia fino a qualche decennio fa.

Alcuni immagini dell’antichità non devono trarre in inganno. In Sicilia a Piazza Armerina, provincia di Enna, la famosa “sala delle dieci ragazze” della villa romana del Casale, patrimonio Unesco, databile attorno al terzo-secondo a.c. raffigura delle giovinette intente ad esercizi di atletica, indossanti un completo a due pezzi, indumento tipico femminile pratico e funzionale allo svolgimento di esercizi ginnici a terra, della danza, del gioco della palla, ma non per il nuoto. A lungo ed a torto si è speculato attorno a questa immagine fraintesa quale prassi antesignana romana del costume femminile del “bikini“, cioè il tanga di Réard del 1946, di cui si scrive più avanti in questo articolo, giacchè non lo è affatto: dall’immagine in alto in prima fila la seconda ragazza tiene in mano una palla; nella fila in basso la seconda ha un cerchio, le ultime due fanciulle giocano a palla, tali attrezzi alludono tipicamente alla ginnastica artistica ed a corpo libero, non ad attività natatorie, infatti, ed in aggiunta, dal mosaico in questione l’ambientazione raffigurativa è priva di sfondi acquei. In età romana la parola “bikini” era sconosciuta come ignorata l’esistenza dell’atollo omonimo dell’arcipelago Marshall nell’Oceano Pacifico e l’espressione “costume da bagno” non esisteva di conseguenza anche al fatto che non è nota l’esistenza, sempre che ci sia stata, di modelli di abiti usati dalle donne e dagli uomini nelle terme romane con le annesse tre piscine a temperature differenziate per fini curativi, la cui frequentazione era rigorosamente separata. Molto probabilmente si immergevano svestiti. Altro non è dato sapere, eccetto che il nuoto è stato giustificato unicamente per ragioni di salute e praticato in luoghi protetti quali le terme, oppure dalle classi basse per necessità sia alimentare della pesca che della vendita medesima e fino al rinascimento è stato considerato di moralità dubbia dalle classi elevate se esercitato per finalità ricreative. E’ l’ambiente termale il luogo di origine dei primi vestimenti sia femminili che maschili idonei seppure ingombranti e castigati, alla balneoterapia, ma non da spiaggia. Dai diari di viaggio di Celia Fiennes, vissuta nel diciassettesimo secolo, ristampati integralmente nel 1947, a proposito della stazione termale inglese Bath si apprende, che nel 1687: “Le dame entrano nel bagno con vesti di bella tela gialla, rigida e larga, con grandi maniche come una veste da parroco; l’acqua le riempie in modo da non lasciare intravedere le forme femminili (…) I signori hanno soprabiti dello stesso tipo di tela, questa è il tessuto migliore”. Ancora a Bath nel 1737 era affisso in bella vista il regolamento della compagnia termale, riportante le prescrizioni precise per l’abbigliamento sia femminile che maschile: “È stato stabilito e decretato da questa Società, che nessuna persona di sesso maschile di età superiore ai dieci anni potrà in qualsiasi momento d’ora in poi entrare in uno o più bagni all’interno di questa città di giorno o di notte senza un gilet [NdT: soprabito smanicato lungo sino al ginocchio secondo l’accezione etmologica e l’usanza vestiaria maschile fino al 19. sec.] sul loro corpo (…) Nessuna persona di sesso femminile potrà mai entrare in uno o più bagni all’interno di questa città di giorno o di notte senza un decente vestimento sul proprio corpo”. La frequentazione delle località sia termali che balneari si diffuse e prestava adito ad osservazioni satiriche letterarie, di cui la più famosa è riportata da “The expedition of Humphry Clinker” l’ultimo romanzo semi-autobiografico del drammaturgo-chirurgo scozzese T. Smollett del 1771: “Le dame indossano giacche e sottane di lino bruno, cappelli, dove si sistemano i fazzoletti per asciugarsi il sudore dal viso; ma in verità, sia che sia per il vapore che le circonda, o per il calore dell’acqua, o per la natura del vestito, o per tutte queste cause insieme, sembrano così arrossate, e così spaventose, che volgo sempre il mio sguardo altrove”. Tale era la reazione disgustata e di disapprovazione, si mal celava l’opinione diffusa secondo cui era sconveniente l’attività acquatica femminile.

Di contro dall’altra parte dell’oceano dal 1767 al 1769 Martha Washington, moglie del futuro primo presidente americano, era stata una disinvolta frequentatrice delle terme di Berkeley Springs, West Virginia, dove non disdegnava indossare gli adeguati costumi da bagno, il cui modello era simile ad una sottoveste, a trapezio non aderente, in tessuto di lino, dall’orlo dotato di pesini di piombo per evitare, che l’abito si sollevasse modo sconveniente in acqua, il cui esemplare è conservato presso il museo del George Washington Mount Vernon. Se il tipo di tessuto usato variava da paese in paese, poteva essere lino, tela, flanella oppure lana, in ogni caso tessuti spessi e non trasparenti una volta inzuppati d’acqua, invece non mutava il principio della “modestia”, cioè abiti pudici, coprenti fino al polso ed alle caviglie, larghi abbastanza da non lasciare intravedere le forme femminili tanto più nel diciottesimo secolo allorquando i bagni di mare divennero un’attività più diffusa, incoraggiata dalla convinzione dei benefici arrecati alla salute. Intanto nello stesso secolo le parigine più abbienti scoprirono le coste della Normandia, la riviera mediterranea e le sponde lacustri, dove indossavano un abito con corpetto e calzoni, in tela spessa da marinaio, coperto sovente da una grande gonna.
Le misure protettive del decoro pubblico si intensificarono in età vittoriana, quando venne introdotto l’uso di cabine balneari mobili progettate per evitare l’esposizione di persone in costume da bagno, soprattutto del sesso opposto. Erano piccole capanne di tela e legno su due ruote, dove le donne entravano vestite di tutto punto. Una volta che le cabine venivano trasportate in acqua ad una profondità sufficiente, allora esse potevano cambiarsi di abito ed immergersi direttamente lontano dalla vista maschile. Come misura estrema a corredo della protezione del pudore era la scelta dei colori, tutti rigorosamente scuri sia per i costumi da bagno che per le cabine mobili. Va detto, che tra la pesantezza dei tessuti e le loro fogge scomode poco agio beneficiava la pratica del nuoto alle rare persone in grado di esercitarla. Chi non poteva concedersi l’onere economico di una cabina, si avvolgeva in abbondanti mantelli chiusi fino al collo prima di immergersi in acqua, ma soltanto laddove l’opzione era consentita.
Attorno la fine dell’epoca vittoriana andò in voga, pur sempre in colori scuri, il “costume da principessa”, il “princess”, un abito intero composto da una camicetta attaccata ai pantaloni, coperti da una lunga gonna fino al polpaccio, il cui orlo andò via via accorciandosi fino al ginocchio con i nuovi modelli ed i materiali furono scelti sempre più, seppure lentamente, per la loro leggerezza consentendo l’acquaticità dei movimenti. Il cambiamento fu apparentemente minimo, perché in realtà riscontrava l’accettazione comune dell’opinione pubblica verso l’attività natatoria delle donne. Addirittura in Francia si osarono abiti da bagno privi di maniche, corti al ginocchio e più aderenti. In entrambi i casi furono ridotte le ampiezze delle gonne e dei mantelli, imperversarono i pantaloni alla “zuava”, vennero vivacizzati i colori dei tessuti con i motivi a righe bianco-blu ed i primi decori marinari cioè la cosiddetta moda “navy”, alla marinara, le cuffiette ed i cappellini furono sostituiti dai foulards lavorati con i primi tessuti impermeabili, le calzature traforate lasciavano scoperti i piedi ed erano munite di stringhe da allacciare alle caviglie, i parasole erano coordinati agli indumenti da bagno.
Tuttavia furono ancora preservati i codici severi di abbigliamento sia alle terme che al mare, parimenti persisteva il contenimento della popolarità tanto della pratica natatoria che dell’esposizione solare ritenuta fino ad allora tabù per i canoni estetici della pelle eburnea, ma qualcosa di epocale avvenne da lì a poco grazie all’inventore dell’elioterapia, originariamente denominata “fototerapia”, la tecnica curativa basata sull’uso della luce, cioè lo scienziato siciliano Sciascia a seguito di suoi esperimenti a scopo terapeutico iniziati nel 1890 e resi noti nel 1892. “Ho l’onore di presentare per la prima volta a questa scientifica adunanza una nuova medicazione, basata sull’energia luminosa e che propongo di denominare Fototerapia” sono le parole da lui usate all’esordio della lettura della sua relazione al tredicesimo Congresso Oftalmologico di Palermo svoltosi il 14 aprile 1892 e similmente all’undicesimo Congresso Medico Internazionale di Roma nel 1894, la cui comunicazione integrale fu riportata per intero dal “Pacific Journal Medical” in America, oltre che dalle pubblicazioni specialistiche in Italia, dove i più insigni cattedratici e direttori clinici italiani gli tributarono il merito in qualità di “geniale fondatore della fototerapia scientifica“. Elogi furono espressi dal giornale medico “Il Policlinico” di Roma, dalla “Rivista medica” di Milano, da “Il Pensiero Sanitario” di Napoli, dall’ordine dei medici di tante province ed addirittura la prestigiosa Società Editrice Dante Alighieri compendiò un intero volume alla sua opera di scienziato “La fototerapia“, edito a Roma nel 1902. In altre parole aveva scoperto le proprietà curative derivanti dall’esposizione alla luce di diverse malattie quali le piccole neoplasie, la congiuntivite, le ulcere, le ferite e le malattie della pelle attraverso il dosaggio dei raggi incandescenti emanati dal “fotocauterio” lo strumento da lui inventato, presentato in sede del congresso sopramenzionato ed il cui brevetto ottenne nel 1894 dal governo di Crispi in Italia, poi anche in Gran Bretagna e Francia, dove fu commercializzato. L’apparecchiatura in questione “addomestica” la luce, montata su un braccio mobile per regolarne la distanza di applicazione. “Nell’adoperare lo strumento, – scrive – avendo osservato, che quanto più io lo avvicinava o allontanava dalla distanza focale avveniva una graduazione nella intensità dell’energia luminosa, determinando un’azione biologica differente dalla cauterizzazione, volli studiare questa risultanza per l’uso medico, nelle malattie della superficie cutanea. Con esperimenti fotografici posteriori mi convinsi che l’azione della Luce può estendersi profondamente nei visceri, e l’applicai alla cura delle malattie interne. Il risultato ottenuto superò l’aspettativa per le sollecite guarigioni avvenute“. Al suo ingegno sono dedicate interessanti pagine da “Google Arts & Culture”; il “fotocauterio” da lui inventato è visibile sul sito della storia della radiologia curato dall’università di Palermo e la sua biografia riportata dal testo “I siciliani” di G. Savatteri edito da Laterza nel 2006. Nonostante l’acclarata attribuzione a lui quale scienziato precursore studioso dei benefici dell’elioterapia ed inventore della strumentazione curativa, meriti riconosciuti persino in America a fine ottocento, purtroppo la fortuna arrise Finsen, medico danese presente al congresso di Palermo nel 1892, dove non presentò nessuno studio, si limitò ad ascoltare gli interventi di altri studiosi, inclusa la tesi rivoluzionaria di Sciascia sugli studi dell’elioterapia, si appropriò dei meriti dello scienziato italiano, pubblicò qualche testo nel 1899, non prima, e nel 1903 vinse il premio Nobel proprio per i suoi presunti studi sulla fototerapia. Purtroppo le dimostranze documentate di Sciascia, le testimonianze e le perorazioni dei colleghi non servirono a nulla, il verdetto della giuria del Nobel non mutò ed oggi rimbalza ancora il nome di Finsen quale scopritore dell’elioterapia.
All’inizio del novecento la diffusione degli studi afferenti i benefici curativi derivanti dall’esposizione solare si riverberò subito nelle stazioni termali, alcune preesistenti, altre potenziate, che divennero tappe ambite dalla buona società, pur sempre con cautela per bandire l’abbronzatura ed evitare gli effetti negativi della luce solare facendo la fortuna delle prime case cosmetiche con la produzione di creme schiarenti e correttive delle “imperfezioni estive”, come ai tempi venivano definite. E’ il periodo fulgido di Salsomaggiore, Fiuggi, Montecatini in Italia, mentre all’estero Aix-le-Bains. Seppure gli itinerari termali fossero preferiti, le classi abbienti iniziarono anche ad acquisire la consuetudine del soggiorno al mare con particolare predilezione a Viareggio, al lido di Venezia, a Rimini e l’incantevole Costa Azzurra. Ovviamente la moda si adattò con tagli sartoriali più idonei e distinti per il semplice passeggio nelle località balneari da quelli specifici da balneazione: l’accorciatura degli abiti; il trionfo del lino, dei ricami e dei merletti per i capi di abbigliamento; le camiciole copri-costume precorritrici degli “chemisiers”, abiti da città in voga più tardi negli anni sessanta; gli ombrellini parasole ed i cappelli, meglio se di paglia, perfettamente coordinati alla toilette sia da passeggio che in spiaggia; i primi costumi interi ed i “pagliaccetti”, seppure realizzati in lana, scelta prevedibile di tessuto non trasparente né aderente se bagnato, anche se molto deformabile e facile al cedimento da comprometterne la pudicizia; le prime cuffie da bagno in materiale impermeabile come lo erano stati i foulards verso la fine dell’ottocento; l’affermazione massiccia del modello “navy”, alla marinara, già presente in età vittoriana, più frequente sia per gli abiti da passeggio che per i costumi di bagno, trasformatosi nella versione da città negli anni sessanta. Insomma è l’esplosione della “Belle Époque” e del “Grand Tour”! E’ nel contesto epocale, che assieme alla cultura dei bagni di sole con mille precauzioni tra creme schiarenti e parasole si infervora il bisogno di sport all’aria aperta, soprattutto il nuoto, ma l’abbigliamento, seppure migliorato quanto ad orli e “mise”, non era ancora del tutto comodo, occorrerà aspettare gli anni venti e l’ingegnosità di un imprenditore americano di una piccola azienda di maglieria: C. Jantzen. Nel 1916 costui assieme ai fratelli Zehntbauer fondò la “Portland Knitting Company”, facendo confluire la vecchia azienda di famiglia “Jantzen Inc.” costituita a Portland, Oregon, nel 1910. Produceva e vendeva in proprio al dettaglio maglioni, calzetteria di lana ed altri articoli lavorati a maglia in un piccolo negozio a Portland, cittadina nota per il “Portland rowing club”, il circolo dei canottieri, di cui sia Jantzen che i suoi nuovi soci erano componenti e fornitori delle tute di canottaggio. Nel 1913, cioè prima della fusione societaria, a seguito della richiesta di uno sportivo canottiere Jantzen abbozzò una tuta da canottaggio più idonea anche per il nuoto sempre di maglia di lana, lavorata a coste, ma con due novità importanti per la leggerezza e le trame di sottili fili elastici, qualità vincenti per l’agevolezza della pratica natatoria e per l’indeformabilità del capo di abbigliamento. Dopo prove, collaudi e verifiche della funzionalità del nuovo tessuto, il jersey di lana, il suo progetto fu definito nel 1915 ed al termine della prima guerra mondiale, nel 1920, lui gestì la campagna promozionale nazionale con l’immagine, disegnata da Frank e Florenz Clark, della “Red diving girl“, la tuffatrice in rosso, che divenne il logo dell’azienda riconoscibile a livello internazionale in virtù della pubblicità sul suo catalogo aziendale, su importanti riviste quali Vogue e Life.

Nel 1923 lanciò la produzione del costume da bagno per le donne dalle medesime caratteristiche tessili del modello maschile, preservando l’etichetta con il logo sugli stessi capi, con l’aggiunta di qualche piccolo accorgimento per le maniche più corte, fino a sparire del tutto, e la scopertura del ginocchio, una novità assoluta riservata al pubblico femminile, che apprezzò molto per la conquistata libertà di movimento garantita dall’innovazione del jersey di lana. Come era prevedibile, fu un successone assicurato da miriadi di richieste di ordini, di vendite, di acquisti, di stabilimenti in tutto il globo, inclusa l’Europa e finanche di negozi con la vendita esclusiva a Parigi. Addirittura il costume femminile da bagno Jantzen, i cui modelli sono stati rinnovati al passo con i tempi, perdura da oltre un secolo ed è divenuto uno status symbol longevo da Ginger Rogers alla principessa Diana ed oltre nella contemporaneità.
All’invenzione del jersey di lana seguirono più o meno gli stili dello stesso prototipo Jantzen, ma differenziati per colore, fantasie e per continente. In America se l’industria tessile propese alla standardizzazione dei tessuti, immise nel mercato i modelli pratici, sportivi consoni alle caratteristiche della donna americana e comunque a costi accessibili dalla classe media; invece in Europa la produzione distinse due fasce di mercato, l’una più facoltosa, la cui priorità era l’eleganza ed il tessuto prediletto era il jersey di seta, mentre l’altra decisamente modesta con possibilità di acquisto a prezzo contenuto, quindi il materiale era ancora la lana. In ogni caso europee, americane, ricche e povere, tutte poterono dedicarsi con agio di movimento agli sport acquatici. Ancora maggiore con l’arrivo degli anni trenta, quando ulteriormente il costume di bagno diventò più scollato, sgambato e le maniche scomparvero. L’evoluzione dei modelli del costume da bagno subì una battuta d’arresto conseguente alla seconda guerra mondiale in primo luogo per la drammaticità del periodo e poi per la priorità di utilizzo di materiale tessile vario, cotone, seta, nylon, lana per le divise ed altre priorità militari, secondo le prerogative stabilite dalle disposizioni governative dei paesi in conflitto. Per il consumo di massa la carenza di tessuti continuò per qualche tempo dopo la guerra, il cui termine coincise con il riavvio delle attività economiche a pieno ritmo in molti settori, con la novità assoluta delle ferie retribuite in alcuni paesi, condizioni favorevoli affinchè si recuperasse la vita ordinaria per molte famiglie e si scoprisse il tempo libero da dedicare alle vacanze in sistemazioni economiche alla portata di tutti, seppure si è lontani dal boom del turismo di massa.
Anche un certo J. Heim riprese un suo vecchio progetto: il lancio del costume a due pezzi. Francese, figlio di ebrei polacchi, costumista per il teatro ed il cinema, direttore della sua omonima casa di moda chiusa alla sua scomparsa nel 1969, annoverò tra le sue clienti Yvonne de Gaulle, moglie del presidente francese; Mamie Eisenhower, moglie del presidente americano; l’attrice Gloria Swanson, la regina Fabiola del Belgio e Sophia Loren. Nel 1932 aveva già creato un costume da bagno a due pezzi composto da un reggiseno con volant e calzoncini alti fino al giro-vita, che aveva chiamato “atome” a causa delle sue ridotte dimensioni, progetto accantonato a causa della persecuzione nazista antisemita e poi dell’avvento del conflitto mondiale. Ebbene nel giugno 1946 rilanciò la sua creazione con lo slogan “il costume da bagno più piccolo del mondo“. Purtroppo per lui il 5 luglio dello stesso anno sempre in suolo francese L. Réard, gestore di un negozio di lingerie ereditato da sua madre ed i cui clienti abituali erano sia gli avventori che le spogliarelliste del “Folies Bergères“, offuscò l’originalità pregressa di Heim, giacchè invitò i giornalisti francesi alla conferenza-stampa di presentazione presso la Molitor, una popolare piscina pubblica a Parigi all’epoca, dello stesso modello con la variante dei calzoncini corti, con l’ombelico scoperto, ad altezza inguinale–puberale, di fatto preciso ed identico all’odierno tanga, quindi più ridotti del modello di Heim, con gran scandalo dell’opinione pubblica e massivamente seguito dalla stampa, anche quando con dispendio di danaro organizzò campagne pubblicitarie sensazionalistiche con velivoli sulla Costa Azzurra. Era riuscito nel suo obiettivo: monopolizzare l’attenzione verso di sé peraltro avvalendosi dello stratagemma del nome scelto per il suo costume a due pezzi “bikini” suggeritogli dall’omonima denominazione dell’atollo delle isole Marshall, dove furono testate le bombe atomiche americane il 1. luglio 1946, convinto dello scalpore “esplosivo”, metaforicamente inteso, che avrebbe suscitato per le ridottissime dimensioni. notizia che ovviamente riempì le pagine dei giornali per settimane e settimane, entusiasmò gli uomini, cle lo sommersero di lettere di ringraziamento per la possibilità della pressocchè integrale visione della nudità femminile negli spazi pubblici, nella vita ordinaria, concedendo in senso lato il passaporto all’ideale femminile della spogliarellista tipico di un certo maschio medio. Per scelta morale ed editoriale di questo sito contrario alla mercificazione del corpo femminile, sia materiale che figurativa, non si pubblica l’immagine della conferenza-stampa di Réard con la spoglierallista indossante il suo bikini del tutto identico agli odierni tanga: è obiettivamente oscena ed offende la rappresentazione delle donne impegnate alla valorizzazione dei propri sani diritti. Nel bene e nel male il nome si impresse indelebilmente nell’opinione pubblica, impressionò l’immaginario collettivo. Inoltre da furbo stratega del marketing Réard depositò il brevetto, accortezza che gli garantì di imporsi sul mercato nazionale, avviò un negozio per la vendita di bikini, i cui proventi gli garantirono agiatezza per quarant’anni fino alla sua dipartita e non creò nient’altro. Tuttavia nel 1956 Heim, il vero creatore originale del costume a due pezzi, ebbe la sua rivincita, quando all’inizio della sua carriera l’attrice Brigitte Bardot si fece fotografare con uno dei suoi modelli essendo alla ricerca di pubblicità e di paparazzi per promuoversi sulla stampa in modo sensazionalistico. Si consideri, che il costume a due pezzi fu considerato scandaloso per molto tempo ancora persino il modello castigato di Heim. Già a partire dagli anni trenta esistevano alcune versioni, in ogni caso coprenti fino alla circonferenza della vita, suscitando disappunto soprattutto in America oltre che altrove anche in Europa. Era ritenuto indecente indossarlo ed il suo uso in spazi pubblici era punito come oltraggio al pudore, pertanto vennero adottati altri stili con il gonnellino a volant esclusivamente per abbronzarsi oppure a bordo delle barche. Intanto dagli anni cinquanta si diffusero le prime camicette annodate in vita, i primi short ed i pantaloni alla pescatora consentiti nelle località balneari, non in città, mode per addomesticare il gusto dell’opinione pubblica ed anticipatrici di altri costumi drasticamente più ridotti da allora alla storia più recente. Nel corso dei decenni nuovi ritrovati tessili hanno consentito una maggiore elasticità ai costumi da bagno, in particolare l’elastam, fibra sintetica di poliuretano, i cui studi cominciarono presso i laboratori di ricerca della Bayer in Germania nel 1937, vennero definiti nel 1951, seppure la prima produzione tessile collaudata sia avvenuta più tardi, esattamente nel 1958 fu introdotta la lycra dall’omonima azienda, un tessuto in grado di asciugare velocemente la pelle e nel 1964 dallo stilista fiorentino E. Pucci fu creato il primo costume da bagno elasticizzato.
Quanto all’abbronzatura nel corso dei decenni gli standard della bellezza sono mutati, pertanto dal tabù della pelle dorata dall’esposizione solare si è passati alla sua ostentazione come traguardo di un benessere economico acquisito ovviamente da parte delle classi meno abbienti, in quanto chi detiene la capacità di solvenza, può permettersi una vacanza. Mentre per le persone più agiate è stato un modo di affermare l’affrancamento dai canoni estetici passati. In ogni caso non è stata affatto una consuetudine introdotta da Coco Chanel, che è un falso come attestano gli studi compiuti da P. Ory, docente emerito di storia contemporanea all’università della Sorbonne, compendiati nel suo libro “L’Invention du bronzage”, edito da Flammarion nel 2018.
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
avete apprezzato l’articolo? condividete il link via facebook e gli altri canali social media