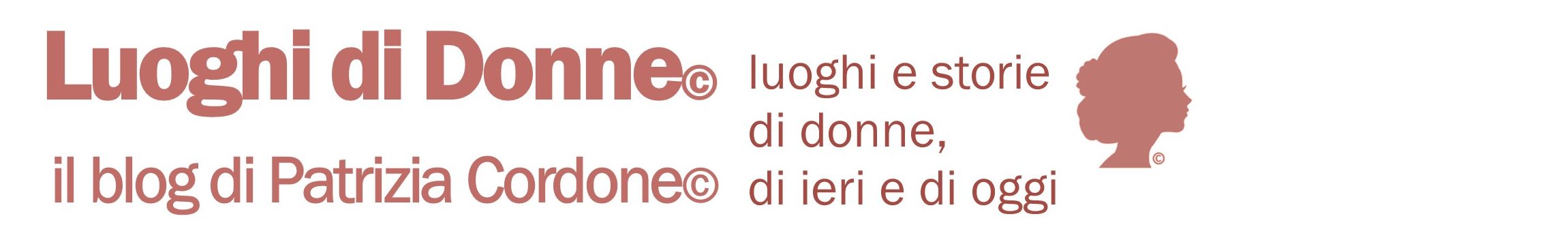Studiosa affermata in Francia, saggista, editorialista per prestigiose testate giornalistiche, consulente di progetti scolastici francesi mirati all’integrazione, con cognizione di causa avverte dei seri pericoli della radicalizzazione dell’islamismo politico in occidente a causa della globalizzazione.
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
La sua preoccupazione maggiore é rivolta al destino delle donne sia immigrate in occidente che residenti nei paesi a regime islamico cancellate da un’ambigua tolleranza alla pluralità delle idee, in realtà ancora vittime della doppia discriminazione in base al sesso ed alla provenienza geografica: sono loro le invisibili, cancellate dal dibattito corrente. La laicità deve essere la parola d’ordine per la loro emancipazione. Nel 1954 nata in Iran ha vissuto nel suo paese fino all’avvento dell’islamismo del regime oscurantista di Khomeini. Dopo aver partecipato attivamente alla rivoluzione iraniana del 1979, la sua opposizione al potere islamista l’ha costretta all’esilio. Nel 1982 in quanto militante di sinistra è stata perseguitata politica proprio a causa del cambio di guardia e quindi é stata costretta all’esilio rifugiandosi in Francia. Qui intanto che ha abbozzato i primi racconti, pubblicati nella raccolta intitolata “Chemins et brouillard” nel 2005.
Ha continuato gli studi, nel 2009 ha conseguito un dottorato in sociologia presso l’Università di Paris-Dauphine si è laureata con una tesi attinente l’islamismo politico con tanta soddisfazione considerato che ha ricevuto il Premio Le Monde per la ricerca universitaria nel 2010. L’anno successivo con il titolo “Political Islam, Sex and Gender, alla luce dell’esperienza iraniana” è stata pubblicata dalla Presses Universitaires de France. Quattro anni dopo con “Demand in the mirror” pubblicato da “L’Âge d’homme” ha esordito in qualità di romanziera. In esilio non ha mai smesso di analizzare e di denunciare la pericolosa deriva dell’islam politico sia con la scrittura che con l’adesione ad importanti appelli quali quello di Insieme contro il nuovo totalitarismo, la risposta di alcuni intellettuali alle violenze fisiche e verbali seguite alla pubblicazione delle Caricature di Maometto sul Jyllands-Posten a difesa dei valori del secolarismo e della libertà. Particolare attenzione rivolge con tenacia al maschilismo all’interno delle comunità immigrate. Dal 2004 al 2014 a riguardo è stata incaricata della direzione dell’Adric, l’Agence de développement des relations inter-culturelles pour la citoyenneté – l’Agenzia per lo sviluppo delle relazioni interculturali per la cittadinanza, con la cui sigla sono state pubblicate due guide: “Face aux violences et aux discriminations: accompagner les femmes issues des immigrations”, Affrontare la violenza e la discriminazione: sostenere le donne di origine immigrata e “Agir pour la laïcité dans un contexte de diversité culturelle. Des idées reçues à une pratique citoyenne”, Agire per la laicità in un contesto di diversità culturale. Dalle idee preconcette alla pratica civica . Queste guide hanno ricevuto il riconoscimento “Année européenne du dialogue interculturel” nel 2008. Il suo ultimo lavoro “Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir” (Éditions iXe, 2019) offre un viaggio tra due generazioni attraverso l’immagine di Simone de Beauvoir e le affermazioni che porta con sé. Dal 2016 ad oggi >é componente dell’Alto Consiglio per la parità tra donne e uomini della Repubblica francese.
Ovviamente ha una profonda conoscenza della storia contemporanea dell’Iran, dalla rivoluzione costituzionale del 1906-1911 alla rivoluzione islamica del 1979. In questo spettro e specularmente ha studiato con dovizia l’evoluzione delle rivendicazioni femministe cioè la condizione femminile iraniana antecedente alla “rivoluzione” del 1979, le rivendicazioni emerse dagli anni Ottanta all’interno della diaspora iraniana in esilio, poi le rivendicazioni del movimento femminista all’interno del paese ovviamente anche in relazione comparata con il femminismo francese.
In più circostanze e con tutti i mezzi, i romanzi, i saggi, gli articoli, le interviste rilasciate, sta allertando del pericolo dell’islamismo politico e della carentissima analisi dell’immigrazione declinata al femminile. A più riprese rimarca il pericolo incombente della dimensione totalitaria dell’islamismo come ideologizzazione dell’Islam in strettissimo rapporto alla globalizzazione, la quale costituisce il terreno fertile per la crescita massiva dell’ideologia politica islamista. Ancora una volta non lesina di sottolineare la colpevole trascuratezza del destino delle donne immigrate e-o autoctone residenti nei paesi islamici, più esattamente punta il dito contro il generico solidarismo verso la condizione degli immigrati offuscante la principale questione di fondo: il violento maschilismo insito in molti di loro e la condanna al silenzio delle donne costrette alla doppia discriminazione, in base al sesso ed allo status di immigrate. La cancellazione e l’invisibilità delle donne immigrate è pericolosa. L’anomalo senso di appartenenza ad una comunità è identificato dai maschi immigrati con i cliché intrisi di virilità bellicosa, più a rischio sono i giovani alla ricerca dell’omologazione identitaria al gruppo e purtroppo, fa notare la studiosa, “l’islamismo, ma anche altri estremismi, offrono un’offerta ideologica che consente ai ragazzi di valorizzarsi attraverso il dominio maschile”. I modelli offerti alle ragazze sono i ruoli di mogli e madri secondo la gerarchia dei sessi in posizione subalterna e secondo il condizionamento misogino. Lei stessa aggiunge: “questa gerarchia di genere, essa stessa costruita sulla misoginia e l’omofobia, è al centro del progetto ideologico-politico di tutti i movimenti basati sull’esacerbazione delle identità religiose“. Dissente sul presupposto della povertà quale causa della diffusione dell’islamismo politico, infatti dichiara: “abbiamo torto nella diagnosi quando diciamo che la povertà o l’esclusione portano all’islamismo è insultare i poveri. L’islamismo è un fenomeno politico e ideologico che attraversa tutte le categorie sociali. Ci sono stati islamisti molto ricchi”.
la bibliografia:
- La femme et le retour de l’islam, Éditions du Félin, 1991;
- Femmes sous le voile : face à la loi islamique (en collaboration avec Farhad Khosrokhavar), Éditions du Félin, 1995;
- Le nouvel homme islamiste : la prison politique en Iran, Éditions du Félin, 2002;
- Chemins et brouillard, Éditions Métropolis, 2005;
- Islamisme et société : religieux, politique, sexe et genre à la lumière de l’expérience iranienne, 2009;
- Islam, politique, sexe et genre, PUF, 2011;
- Demande au miroir, Éditions L’Âge d’Homme, 2015;
- Le Rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, Editions iXe 2019.
articolo di ©Patrizia Cordone – Tutti i diritti d’autore riservati. Sono vietati il “copia-ed-incolla“, il plagio, la contraffazione dei contenuti e di tutti gli usi illeciti a danno della proprietà intellettuale. In ossequio alla normativa dei diritti d’autore e del copyright le infrazioni saranno perseguite con severità e senza indugio presso la competente autorità giudiziaria.
avete apprezzato l’articolo? condividete il link via facebook e gli altri canali social media